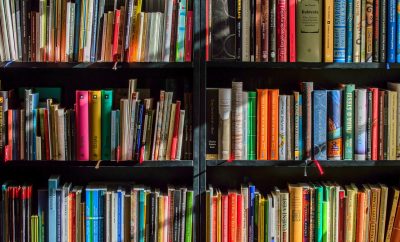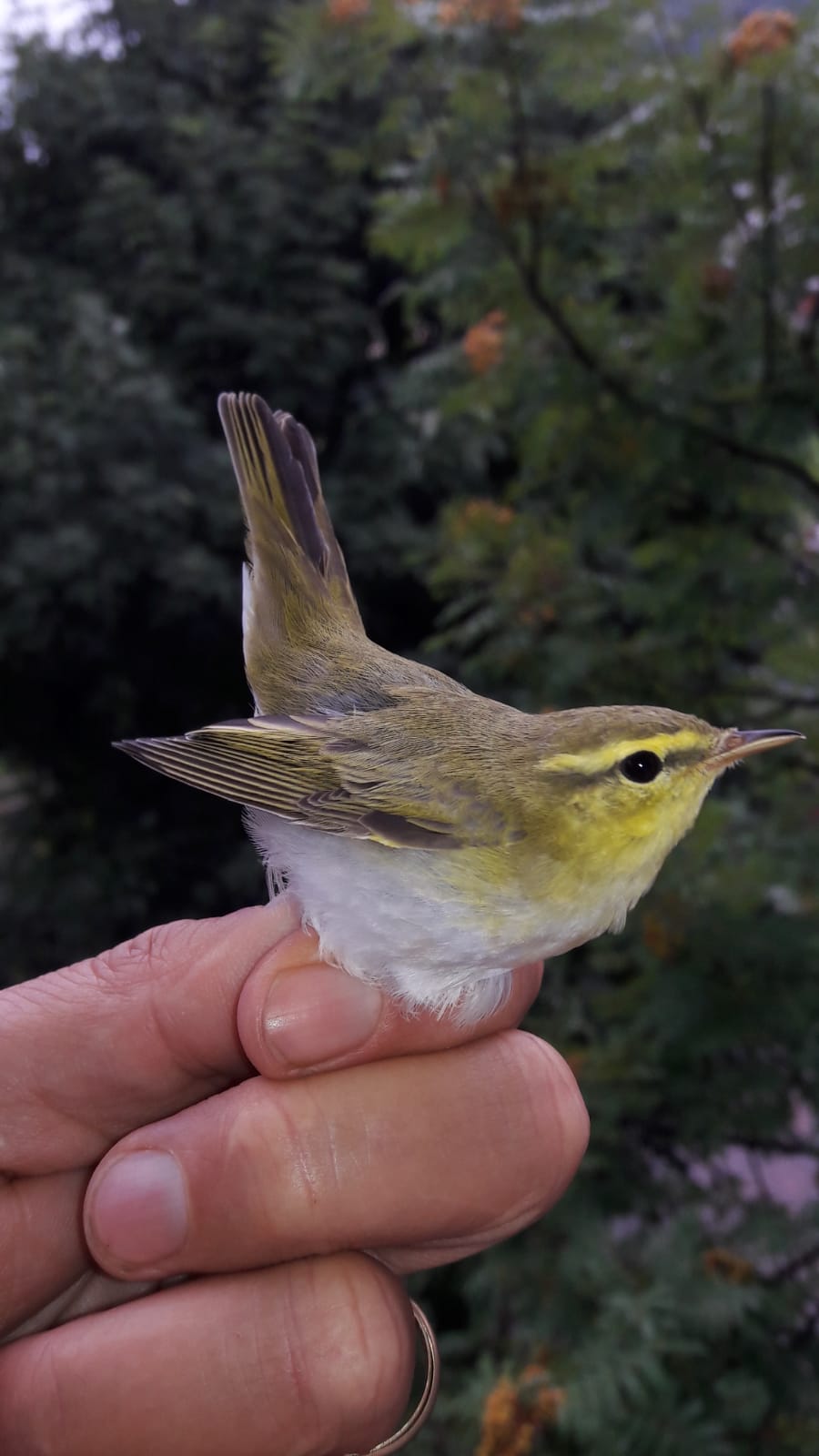A cura di Luca Roner e Antonio Romano
 L’European Congress of Herpetology, evento che si svolge con cadenza biennale, offre agli erpetologi di tutta Europa l’opportunità di ritrovarsi per un momento di confronto e reciproco aggiornamento riguardo alle più recenti ricerche del settore. Quest’anno sarà l’Italia ad ospitare il convegno, che dal 2 al 6 settembre si terrà presso il Museo di Storia Naturale di Milano, trattando numerosi argomenti legati ad anfibi e rettili: ecologia, etologia e conservazione, con particolare attenzione al problema del Batrachochytridium, fungo molto pericoloso per gli anfibi, che si sta rapidamente diffondendo in tutta Europa.
L’European Congress of Herpetology, evento che si svolge con cadenza biennale, offre agli erpetologi di tutta Europa l’opportunità di ritrovarsi per un momento di confronto e reciproco aggiornamento riguardo alle più recenti ricerche del settore. Quest’anno sarà l’Italia ad ospitare il convegno, che dal 2 al 6 settembre si terrà presso il Museo di Storia Naturale di Milano, trattando numerosi argomenti legati ad anfibi e rettili: ecologia, etologia e conservazione, con particolare attenzione al problema del Batrachochytridium, fungo molto pericoloso per gli anfibi, che si sta rapidamente diffondendo in tutta Europa.
All’appuntamento non mancherà la sezione di Zoologia dei Vertebrati del MUSE che parteciperà al convegno con un contributo orale frutto del lavoro svolto nel 2018 dagli autori Luca Roner, Antonio Romano e Paolo Pedrini con la collaborazione del personale del Parco di Paneveggio – Pale di San Martino.
“Trophic ecology of Alpine salamander, Salamandra atra atra” è il titolo della presentazione che Luca Roner illustrerà all’interno della sezione “Ecology and Ethology”. Le salamandre, predatrici di invertebrati che in alcuni casi costituiscono una porzione significativa della biomassa, possono ricoprire un importante ruolo ecologico in un ecosistema. In quest’ottica risulta importante il lavoro effettuato dagli erpetologi del MUSE che, per la prima volta, hanno analizzato in modo estremamente dettagliato l‘ecologia trofica della salamandra alpina (strategia e disponibilità trofica, selettività ecc), fornendo inoltre utili indicazioni sulle metodologie più adeguate per il campionamento della disponibilità trofica effettiva.